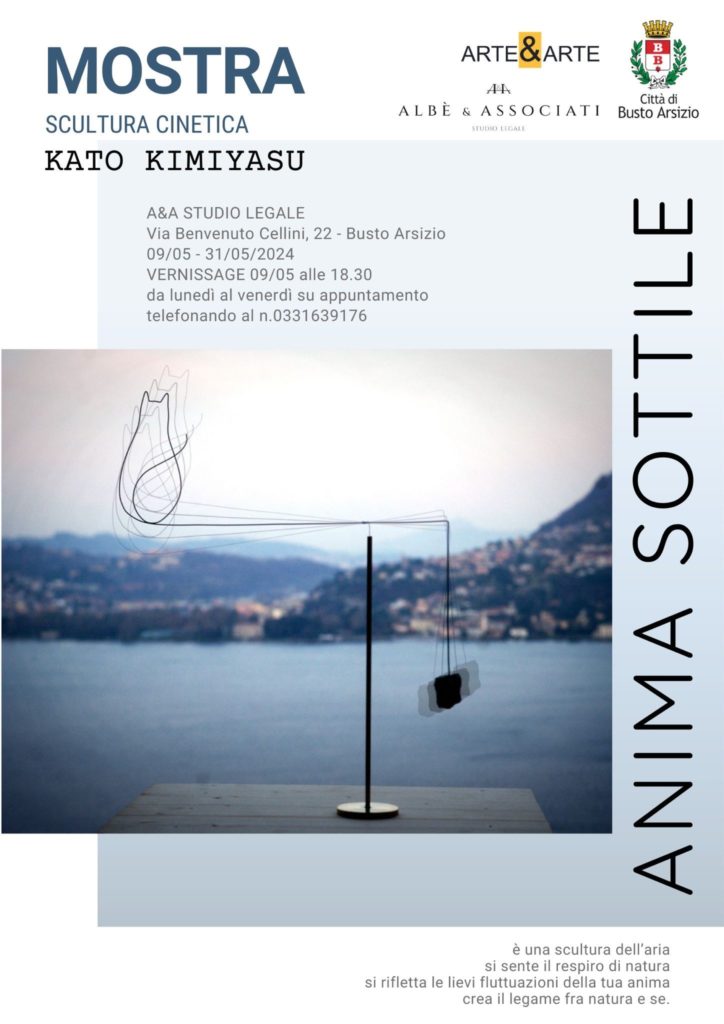Mostra fotografica: Chernobyl, ritratti dell’infanzia contaminata

Mercoledì 20 aprile alle 18.30 in studio a Busto Arsizio si terrà il vernissage della mostra fotografica “Chernobyl, ritratti dell’infanzia contaminata” di Pino Bertelli in occasione del 10° edizione del Festival Fotografico Europeo.
L’ingresso è libero e gratuito.
***
PINO BERTELLI
CHERNOBYL, RITRATTI DELL’INFANZIA CONTAMINATA
NON È MOLTO, NON È POCO
È maledettamente difficile occuparsi degli altri. Non perché non lo si voglia fare, ma proprio perché non si sa bene da dove cominciare: gli aiuti possono sembrare una forma più ambigua di carità, l’attenzione di alcune ore un modo per compensare la dimenticanza di tanti giorni, perfino le parole possono incappare nel temibile rischio della retorica che tutto appiattisce proprio quando, al contrario, si può contrapporre loro la linearità dell’impegno. È proprio quando ci si trova in questi impacci che ci si rende conto della forza espressiva di un linguaggio così particolare e incisivo, così apparentemente disarmato e così profondamente intenso come quello della fotografia. Perché questa aiuta direttamente i soggetti proprio per il fatto di essere posti al centro dell’attenzione, aiuta chi li osserva a prendere coscienza della loro esistenza, aiuta infine tutti in quell’arte così bella, difficile e rara che è la mediazione. I ritratti degli abitanti dell’area intorno a Cernobyl sono un contributo molto importante da questo punto di vista, soprattutto perché lo stile con cui sono realizzati è asciutto, essenziale, antiretorico: per quanto si possa essere poco propensi a stabilire confronti con altri autori del passato, sembra impossibile qui non evocare lo spirito con cui il grande August Sander riprendeva gli uomini del suo tempo per tentare così di costruire un ideale atlante del XX secolo. Non si tratta, peraltro, di una citazione fuori luogo per un autore come Pino Bertelli, che ha a lungo frequentato con acume e intelligenza critica la storia della fotografia. Indagare una realtà difficile e aspra significa spesso, anche conservando le migliori intenzioni, lasciarsi prendere la mano e scegliere la strada della spettacolarizzazione della sofferenza. Qui, invece, la scelta del ritratto permette di contenere questo esito lasciando intatto il forte senso di pietas che caratterizza la ricerca. Spesso sono i bambini i protagonisti: sorridono e qualche volta piangono davanti all’obiettivo, guardano in macchina perplessi e qualche volta spaventati, ma più spesso ostentano con orgoglio un cappello di lana o un golfino dai polsini slabbrati, grandi trecce e un paio di anellini alle orecchie, una pistola giocattolo e qualcosa che somiglia a un arco costruito con un pezzo di legno curvato e una corda annodata. Ma i bambini sono anche fra i personaggi più sofferenti quando capisci la loro forzata immobilità sulle poltroncine, il loro impaccio di down, le loro mani intrecciate in posture innaturali. Il bianconero essenziale di cui si serve Bertelli, la luce livida che domina la scena, l’essenzialità delle situazioni descritte crea un’atmosfera da teatralità tragica dove non mancano certo i personaggi carichi di speranza (sorridono la bella ragazza dagli zigomi alti e quella con le braccia conserte, un’altra sembra sognare seduta sul banco) anche se quasi tutti gli altri raccontano di una vita stentata ben rappresentata dall’uomo che cammina, le spalle insaccate in un giubbotto dalle maniche troppo corte, su una strada polverosa o dalla vecchia che stringe fra le mani come un prezioso bene una forma di pane. Sono i particolari a far più pena: quel pezzo di corda che stringe come una cintura la giacca di un uomo, quei fazzoletti annodati sotto il mento che ricordano l’iconografia classica delle contadine russe, quei pellicciotti con cui alcune donne tentano di difendersi dal freddo, quella giacca a vento troppo stretta indossata dall’uomo che fuma disperatamente, quel gesto con cui una vecchia donna seduta su una panchina con un libro in mano si copre pudicamente il volto. Anche i pochi paesaggi sono desolati e desolanti: le staccionate che sembrano quelle dell’America della crisi del 1929 riprese da Dorothea Lange, il tetto sfondato di una fattoria, il pozzo, perfino la cuccia di un cane sembrano ricordare a tutti noi che le tragedie travolgono sempre i più 3 9 deboli, si accaniscono sugli indifesi, sembrano non conoscere confini dati dalle sfalsature delle epoche, dalla distanze delle latitudini, dall’apparente (o anche reale, che importa) differenza delle ideologie. Resta solo in questa desolata landa dominata dal vicino “sarcofago” del reattore che qui non si vede, anche se la sua è un’ombra ossessivamente presente, ma da cui fuoriescono letali e invisibili particelle. In tutto questo quadro, la fotografia, simbolo della solidarietà rappresenta una speranza. Non è molto, ma neppure poco.
Roberto Mutti