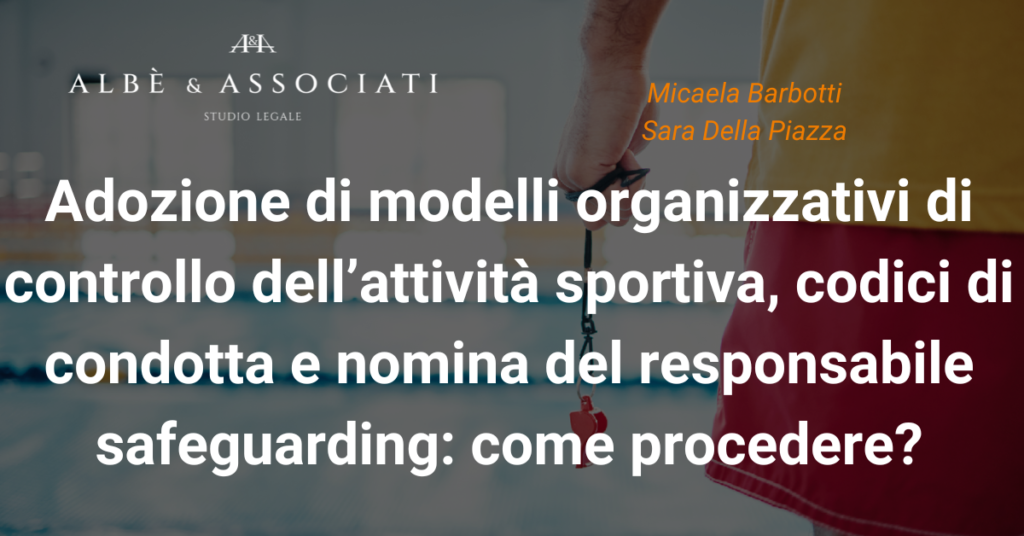Patto di non concorrenza: facciamo il punto?

Sempre più frequentemente si avverte la necessità da parte di aziende di tutelarsi verso i possibili comportamenti illegittimi dei propri dipendenti anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
A ben vedere, anche questo, può essere un segnale della tanto auspicata ripresa.
Uno strumento che permette all’imprenditore di cautelarsi nel senso sopra indicato è il patto di non concorrenza, disciplinato dall’art.2125 c.c., del quale giurisprudenza e dottrina hanno frequentemente precisato i contenuti.
Se, infatti, in costanza di rapporto il dipendente automaticamente non deve, ai sensi dell’art.2105 c.c., trattare affari per conto proprio o di terzi in concorrenza con l’imprenditore, per limitare l’attività del lavoratore per il periodo successivo alla cessazione del rapporto è, invece, necessario, stipulare, per iscritto, uno specifico accordo.
Circa l’obbligo ex art.2105 c.c. si segnala che con la recente sentenza n.8131 del 29 marzo 2017 la Cassazione ha riaffermato alcuni principi tra i quali, in particolare, quello secondo cui tale obbligo deve essere integrato con i principi generali di correttezza e buona fede, con la conseguenza che lo stesso deve intendersi come divieto di condotte che siano in contrasto con i doveri connessi all’inserimento del lavoratore nell’organizzazione dell’impresa o che creino situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi dell’impresa o che siano comunque idonee a ledere in modo irreparabile il vincolo fiduciario.
Ciò chiarito, torniamo ora al patto di non concorrenza, per analizzarne le caratteristiche.
Come accennato, tale patto richiede, per la sua validità, la forma scritta.

La legge non prevede un momento particolare per la stipulazione del patto, ben potendo la stessa avvenire contestualmente all’assunzione, in costanza di rapporto, all’atto della cessazione del rapporto stesso o, addirittura, anche dopo la cessazione.
Parimenti la legge non individua una o più categorie di lavoratori come destinatarie del patto: pertanto, l’accordo può essere raggiunto sia con le figure apicali (si pensi a dirigenti, quadri o impiegati di alto livello) sia con quelle “generiche”.
La legge impone, invece, che il patto con cui si limita l’attività del dipendente dopo la cessazione del rapporto di lavoro sia contenuto entro determinati limiti di tempo, oggetto, territorio e che sia adeguatamente remunerato.
Circa la durata, il patto non può eccedere i cinque anni se riguarda i dirigenti ed i tre anni per le altre categorie.
Se dovesse essere pattuita una durata superiore, la stessa automaticamente si riduce al limite di legge.
Se, invece, non è prevista una durata, non è immediata la nullità dell’accordo ma trova applicazione il termine di legge.
In entrambi i casi, spetterà comunque al giudice valutare la congruità della durata in relazione alle limitazioni dell’oggetto e al compenso pattuito.
Relativamente all’oggetto, il patto può riguardare qualsiasi attività in concorrenza con quella dell’imprenditore: sul punto, la giurisprudenza ha però affermato che nel vincolo non possono rientrare attività estranee allo specifico settore produttivo o commerciale in cui opera l’azienda perché le stesse sono inidonee ad integrare concorrenza.
Ai fini dell’effettiva utilità del patto deve essere impedita al dipendente non solo l’attività in forma subordinata, ma anche quella resa sotto altre possibili forme (ad esempio: consulente, socio, consigliere di amministrazione, agente o anche per interposta persona), prescindendo altresì dalla gratuità o dall’occasionalità dell’attività medesima.
La giurisprudenza ha, comunque, dichiarato la nullità del patto in caso di compromissione di ogni potenzialità reddituale da parte del lavoratore: nessun compenso, per quanto cospicuo, può rendere valida la rinuncia a ogni possibilità d’impiego.
Il patto è altresì nullo se la limitazione territoriale non è stata espressamente determinata.
In alternativa, o in aggiunta, ad una specificazione territoriale dell’estensione del vincolo, è ammessa l’indicazione della denominazione di imprese concorrenti.
Un aspetto che merita particolare attenzione è sicuramente il corrispettivo che deve necessariamente essere riconosciuto al lavoratore a fronte del sacrificio imposto.
In effetti, molte volte, la validità del patto è stata messa in discussione proprio in correlazione all’importo attribuito al dipendente.
Sono, infatti, nulli i patti che prevedono compensi simbolici o sproporzionati (al ribasso) rispetto al sacrificio richiesto al lavoratore.
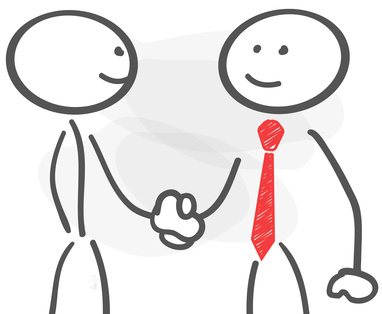
Il corrispettivo va, quindi, previsto in relazione a tutti gli altri elementi del patto (oggetto, durata ed estensione territoriale) e dovrà essere tanto maggiore quanto più sia:
1) elevata la posizione gerarchica del lavoratore e la retribuzione;
2) ampio il vincolo territoriale;
3) ampio il novero delle attività e/o delle imprese individuate come concorrenti;
4) estesa la durata.
È anche possibile che le parti si accordino perché il corrispettivo sia erogato non solo sotto forma di denaro ma si concretizzi, ad esempio, nella remissione di un debito o godimento di un bene per un certo periodo o con altro compenso in natura.
Per quanto concerne le modalità e i termini di pagamento del corrispettivo la legge non prevede nulla.
Sono quindi ammessi, ad esempio, versamenti in costanza di rapporto, alla cessazione del rapporto di lavoro (cioè quando il patto diviene efficace), rateali a partire dalla cessazione del rapporto e per tutta la durata del vincolo (cadenza mensile, trimestrale, annuale, o altra scadenza).
Se il pagamento avviene in costanza di rapporto (si pensi mensilmente unitamente alla retribuzione), è sempre consigliabile:
- determinare l’importo totale dovuto, considerando i singoli pagamenti come acconti, così da non rendere aleatorio l’ammontare e, quindi, potenzialmente incongruo il corrispettivo con conseguente invalidità del patto stesso;
- disciplinare le modalità e i termini di pagamento dell’eventuale saldo;
- specificare nella busta paga – mediante apposita voce – l’importo erogato per il patto di non concorrenza, tenendolo ben distinto dagli elementi propri della retribuzione, così da evitare confusione tra gli stessi.
E’, inoltre, quanto mai opportuno ricordare che è nulla la clausola che concede al datore di lavoro la facoltà di recedere dal patto, ovvero di abbreviarne la durata, dopo la cessazione del rapporto o all’atto della risoluzione del rapporto.
Cosa succede, infine, se il lavoratore viola il patto?
Dal punto di vista processuale, è ammesso per l’ex datore di lavoro il ricorso d’urgenza ex art.700 c.p.c. per chiedere l’emissione di un’ordinanza di cessazione dell’attività vietata.
Le parti possono altresì prevedere, nel testo contrattuale, una penale specifica per l’inadempimento del lavoratore.
Iscriviti alla Newsletter